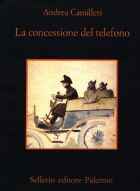|
Sul frontespizio della copertina Camilleri scrive: "Nell'estate del 1995
trovai, tra vecchie carte di casa, un decreto ministeriale (che riproduco
nel romanzo) per la concessione di una linea telefonica privata. Il
documento presupponeva una così fitta rete di più o meno deliranti
adempimenti burocratico – amministrativi da farmi venir subito voglia di
scriverci sopra una storia di fantasia (l'ho terminata nel marzo del
1997).La concessione risale al 1892, cioè a una quindicina di anni dopo i
fatti che ho contato nel Birraio di Preston e perciò qualcuno potrebbe
domandarmi perché mi ostino a pistiare e ripistiare sempre nello stesso
mortaio, tirando in ballo, quasi in fotocopia, i soliti prefetti, i soliti
questori, ecc.. Prevedendo l'osservazione, ho messo le mani avanti. La
citazione ad apertura del libro è tratta da "I vecchi e i giovani" di
Pirandello e mi pare dica tutto. Nei limiti del possibile, essendo questa
storia esattamente datata, ho fedelmente citato ministri, alti funzionari
dello stato e rivoluzionari col loro vero nome (e anche gli avvenimenti di
cui furono protagonisti sono autentici). Tutti gli altri nomi e gli altri
fatti sono invece inventati di sana pianta."
Il messaggio del brano tratto da "I vecchi e i giovani" è di facile
lettura: sia la Destra che la Sinistra parlamentare, quando sono state al
governo hanno trattato la Sicilia come terra di conquista e i siciliani
come barbari da incivilire; in Sicilia arrivarono tutti gli scarti della
burocrazia, furti, assassini e grassazioni eseguite in nome del Real
Governo.
E' proprio questa la Sicilia che appare nel romanzo.
Il periodo storico va precisamente dal 12 giugno 1891 al 20 agosto 1892,
come risulta dalle date della prima e dell'ultima lettera. I luoghi
geografici citati sono: Vigata, comune di Montelusa, Palermo, Fela; ovvero
Porto Empedocle, comune di Agrigento, Palermo, Gela.
Più difficile discernere nel romanzo quali siano i nomi e i fatti inventati
di sana pianta e quali i limiti entro cui siano stati fedelmente citati gli
alti funzionari dello Stato. Le conoscenze storiche del lettore possono
arrivare ai nomi dei ministri di quell'epoca, Crispi, Di Rudinì, Giolitti.
Altrettanto difficile è capire se sia autentico o meno il documento
(pg175-176) del Ministero, Direzione generale di Pubblica Sicurezza,
rivolto ai Prefetti e questori dell'isola, che riassume la preoccupazione
del governo sia per il pullulare nell'isola di società di ispirazione
mazziniana, che si fanno promotrici di scioperi per ottenere aumenti
salariali, sia per il possibile raggruppamento di tutte le società operaie
siciliane in un'unica organizzazione destinata ad assumere la denominazione
di "Fasci dei lavoratori siciliani".
Quanto al "pistiare e ripistiare", termini insostituibili, sulla medesima
realtà storica, posso dire che l'identità di epoca collega solo
cronologicamente questo romanzo con "Il birraio di Preston", che presenta
una sua originalissima storia e un'altrettanto personale struttura. Ben
venga che si capisca che la mano è la stessa.
Il romanzo è articolato in tredici capitoli, sei intitolati "Cose scritte"
intervallati a sei intitolati "Cose dette" e un tredicesimo di "Cose
scritte e dette": questa costruzione crea una esatta corrispondenza tra i
capitoli e sembra ubbidire a un disegno di ordine e di precisione, di fatto
smentito dalla mancanza di una perfetta sequenza temporale nello
svolgimento dei fatti, che sono affidati a corrispondenza privata e a
dialoghi, altrettanto privati, tra due persone.
Un elenco dei personaggi, stilato dall'autore ad introduzione del romanzo,
rende possibile sin dalla prima pagina l'individuazione di destinatario e
mittente per le lettere e dei due interlocutori per i capitoli dialogati.
Sottotitolo del romanzo potrebbe essere: "Tutto in Sicilia è tiatro"
Si tratta infatti di una specie di commedia degli equivoci e degli
imbrogli, che trova la sua ambientazione ideale in un'isola, come la
Sicilia, che è terra di contraddizioni e di "componenda" (vedi "La bolla di
componenda", 1973), che da Camilleri stesso sappiamo significare "accordo,
compromesso, transazione".
L'equivoco, che ridicolmente fa da motore a tutta la storia è lo scambio
tra due lettere dell'alfabeto, la M e la P. Il protagonista, Genuardi
Filippo, per ottenere la concessione di una linea telefonica per uso
privato, fa domanda formale al prefetto di Montelusa, denominandolo
Vittorio Parascianno anziché Marascianno come in realtà il prefetto si
chiama.
Da qui nasce una storia complessa, in cui equivoci e imbrogli non si
contano più e che coinvolge: il Genuardi, siciliano qualsiasi, e la sua
famiglia; i vari apparati dello Stato, ovvero Prefettura, Questura,
Pubblica Sicurezza e Benemerita Arma dei Reali Carabinieri; don Calogero
Longhitano, il mafioso del paese; la Chiesa; quei compaesani, siciliani
qualsiasi, che involontariamente capitano sulla strada di Pippo Genuardi
Il Genuardi, come scrive la delegazione di Pubblica Sicurezza di Vigata, "A
lungo nullafacente, campando sulle spalle della madre vedova, da tre anni
commercia in legnami" E' sposato con la figlia dell'uomo più facoltoso, ma
anche onesto, del paese, che inutilmente si oppose a questo matrimonio dopo
il quale il Genuardi occasionalmente ebbe relazioni adulterine, di cui la
moglie è sempre stata all'oscuro. Da due anni ha messo la testa" a
partito", mantenendo una condotta "senza pecche" e rallentando anche i
rapporti con l'amico Sasà La Ferlita, "vera sentina di ogni deboscio". La
sua vita familiare sembra scorrere senza problemi; Taninè è sinceramente
innamorata del marito e il padre di lei, risposatosi con una donna coetanea
della figlia, ha imparato a tollerare questo genero, che, se non fa
granchè, non sembra combinare neppure guai. Ma qualcosa non quadra, perché
al lettore viene fatta leggere una lettera anonima destinata a "Pippo amori
mio adoratto"; è un indizio che Camilleri, autore di gialli, butta lì
perché il lettore lo colga e lo colleghi ad altri piccoli indizi sparsi
lungo il romanzo. Indizi di che cosa, il lettore accorto può capirlo; Salvo
Montalbano lo capirebbe subito.
Quanto all'amico Sasà, scappato a Palermo per aver contratto debiti di
gioco, il Genuardi è pronto a tradirlo se gliene capita l'occasione o la
necessità.
Il prefetto Marascianno, cui il Genuardi fa domanda della concessione del
telefono, è una macchietta ben riuscita: napoletano, parla "smorfia alla
mano": 12 - 72 - 49, che significano rispettivamente rivolta - incendi -
omicidi ; oppure: 66 – 6 – 43, che equivale a congiura – segreto –
socialista; o ancora: 56 – 50 – 43, e cioè guerra – nemico – socialista. Si
inventa una moglie morta e una fuggita; paventa lo scoppiare sia di una
guerra civile che di una guerra sociale e vede congiure dovunque attorno a
sé; fino a credere che i socialisti stiano infettando le campagne siciliane
con "maleodoranti unguenti" e diffondendo "germi di color rosso acceso",
ciascuno dei quali dotato di "2402 zampine"; pur di arrestare un socialista
arresterebbe una vecchietta di 93 anni perché zia di un socialista. Poiché
in napoletano "Parascianno" significa "barbagianni" e nel gergo più
triviale addirittura "membro virile di gigantesche proporzioni", il
prefetto deduce di essere stato denominato a bella posta dal Genuardi
"grandissima testa di c…".
Camilleri sottolinea sempre le diversità tra regione e regione e le
difficoltà di comunicazione cui tali diversità danno origine. Si tratta
spesso di semplici incomprensioni linguistiche che possono diventare anche
equivoci gravi e determinare il corso delle vicende (come in questo caso),
ma offrono di solito lo spunto per costruire scenette spassose in cui i
personaggi sono guardati dall'autore con ilarità. Nei romanzi di Camilleri
c'è il piemontese, il romano, il napoletano, il bergamasco, il fiorentino,
sempre figure di secondo piano, ma che servono a sottolineare le differenze
di lingua, di abitudini, di tradizioni. Il Questore, bergamasco, parlando
con il commendator Parrinello, siciliano, dice "…lei avrà capito che io
sono uno che dorme con la serva" e si sente rispondere "No, non l'avevo
capito. Ad ogni modo, fatti suoi, lei è padronissimo." perché il siciliano
non può sapere che il modo di dire bergamasco significa semplicemente "Io
sono uno che parla chiaro".
Tornando al prefetto Marascianno, per impedirgli di dire o fare sciocchezze
davanti all'Ispettore il suo diretto sottoposto lo fa scivolare e
percorrere "rotolando, ben due rampe di scale"; per cui "in seguito a
rovinosa caduta…..gli si sono spezzati molari, canini e incisivi" (il che
equivale a tutti i denti eccetto premolari e denti del giudizio, che, si
suppone, siano rimasti al loro posto); ha subito inoltre "frattura del
braccio destro e rottura dei femori". Come non immaginarci un fantoccio
fatto a pezzi?
La Benemerita Arma degli RR CC cui il Tenente Lanza-Turò appartiene è la
polizia di stato e mostra "nella sua inspiegabile persecuzione contro un
cittadino qualsiasi" caratteristiche comportamentali di stile mafioso. Il
Tenente Lanza-Scocca, che "le sta studiando tutte per riabilitare il
cugino" trasferito, agisce con pregiudizio e in modo tendenzioso
segnalando al prefetto (il famoso Marascianno!) di sospettare ("più che il
sospetto") che sia stato il Genuardi stesso a dare fuoco al suo quadriciclo
a motore per incassare i soldi dell'assicurazione. O addirittura usa metodi
illeciti, come lo scasso senza furto nei locali dell'Officio delle Regie
Poste e Telegrafi, per conoscere l'indirizzo del Genuardi, che, impaurito
dal comportamento di don Lollò, si nasconde a Palermo; per non parlare del
vergognoso "tiatro" finale a bella posta messo in scena per portare gloria
a sé stessi e alla Benemerita.
Ma Prefetto e Reali Carabinieri non sono gli unici a rappresentare lo Stato
in Sicilia; ci sono anche un Questore e un Delegato di pubblica sicurezza,
che possiamo chiamare "la controparte". Essi, l'uno bergamasco e l'altro
siciliano vedono e giudicano il Genuardi "uno che santo non è" ma non si
interessa di politica (ha votato sempre secondo i consigli del suocero) e
si interessa molto invece al suo quadriciclo, al quale "teneva assai più
che alla propria vista" e al quale non avrebbe mai dato fuoco "non per
scrupolo ma per l'incerto esito dell'intrapresa".
Don Lollò, ovvero don Calogero Longhitano, ci è presentato da Camilleri
come Commendatore, uomo di rispetto. Così lo definisce anche il Delegato di
pubblica sicurezza "in uno sfogo" con il Questore nel quale confessa di
aver proposto "questa persona di rispetto per il confino di polizia", ma la
richiesta era stata respinta dal Presidente del Tribunale di Montelusa; gli
restituirono anche il porto d'armi che egli era riuscito a fargli togliere
e "con tante scuse"; inoltre "coloro che lo proteggono l'hanno fatto
insignire del titolo degli onesti e degli obbedienti alle leggi!".
Don Lollò è insomma persona che con "sistemi non leciti e con affiliazioni
mafiose è assurto a grande potere". Questi sistemi non leciti ubbidiscono
comunque a una loro etica in quanto il rapporto tra uomo comune e uomo di
rispetto (e viceversa) è regolato da norme precise: lo scambio è sempre
reciproco e segreto; si parla del tutto casualmente di un favore fatto in
segno di amicizia o per dovere di onestà, e, più avanti, nel discorso,
altrettanto casualmente, se ne domanda il contraccambio. "Allora guardi:
noi due non ci siamo mai visti, non ci siamo parlati. Nel suo interesse. A
buon rendere" dice al Genuardi, che gli confida l'indirizzo di Sasà, il
Commendatore, che cerca il La Ferlita per lavare un'offesa fatta da questi
a suo fratello. Perché le offese vanno lavate e i debiti vanno pagati. In
cambio Don Lollò attraverso "persona nostra" facilita al Genuardi le
pratiche per la concessione del telefono; ma quando capisce che Pippo
Genuardi fa il doppio gioco a proposito di Sasà e sospetta, erroneamente,
che sia immanicato con i carabinieri, lo "avverte" bruciandogli il
quadriciclo e in seguito esercitando pressioni su alcuni proprietari perché
non gli concedano il permesso per la palificazione della linea telefonica
che dovrebbe attraversare i loro terreni. Ma è disposto a riconoscere di
aver sbagliato (come a proposito della collusione del Genuardi con i
carabinieri) e anche a far credito. Dal processo per tentato omicidio il
Genuardi deve "nesciri assolto", dice don Lollò, che vuole a tutti i costi
restituire a Sasà l'ingiuria ricevuta, lasciandolo zoppo per la vita e
facendo assolvere chi lo ha reso tale. E i mezzi non gli mancano. Perfino
chi è rinchiuso all'Ucciardone "trasi e nesci"; come l'avvocato Orazio
Rusotto, che "è sbiquo: qualcuno dice che si trova a Messina? Cento persone
giurano che invece è a Napoli".
La Chiesa è indubbiamente considerata un potere. Il Delegato di Pubblica
Sicurezza dice al Questore che "….se appresso al Genuardi, oltre ai
Carabinieri, ci si è messa macari la Chiesa, io a quello lo vedo
fottuto….".
Il tutto nasce dalla confessione fatta da Taninè a Don Pirrotta, che trova
in ciò che gli dice la donna una conferma al fatto che il Genuardi sia un
pericoloso socialista. Egli infatti non solo non frequenta la chiesa ma
propone alla moglie, invece di andare alla messa, di fare all'amore , anzi
lo fa anche "ante retro stante, nell'altro vaso; e farlo nell'altro vaso è
contro natura! E contro natura è macari il socialismo!". E poiché le voci
al confessionale sono alterate e la vedova Rizzopina sente tutto, in paese
circola la voce che "il Genuardi Filippo, ogni volta che assolve al debito
coniugale, si tinge il membro di rosso per parere un diavolo e possiede la
moglie contro natura gridando: viva il socialismo!".
Gli altri personaggi del romanzo, i proprietari dei terreni attraverso cui
dovrebbe passare la linea telefonica, sono tutti soprattutto ridicole
macchiette.
Il Signor Giliberto, sembra voler difendere con affetto paterno l'onore
della figlia Annetta e si definisce "omo di core", ma per qualche migliaio
di lire venderebbe l'anima. I Signori Giacalone costruiscono una
gustosissima scenetta in cui lui si finge inebetito per non dover firmare
il permesso per la palificazione, ma alla fine proclama: "Non ce la faccio
a stari sempri chiuso in casa e a fare finta d'essere addiventato stòlito
solo per fari un piacìri a don Lollò Longhitano!": perché anche recitare
stanca. Il Cavaliere Mancuso "su consiglio" di don Lollò nega al Genuardi
il permesso per la palificazione, ma più tardi, sempre "su consiglio" di
don Lollò deve concederglielo; afferma allora con alterigia di non voler
essere "un pupo", ma fa rapidamente retromarcia con un "mi lasci almeno
sfogare tanticchia", quando capisce che è meglio perdere la faccia che i
favori dell'uomo di rispetto.
La fine del romanzo
Tutti gli equivoci sembrano essersi chiariti: il Genuardi è stato assolto
sia dall'accusa di essere socialista che dal tentato omicidio. Don Lollò ha
lavato l'ingiuria. Ma anche Sasà è siciliano e anche lui ha ricevuto
un'ingiuria, precisamente dall'amico Pippo, che lo ha tradito con don Lollò
. Al Genuardi sono state rivolte due accuse nel corso del romanzo, entrambe
rivelatisi infondate. Sasà si vendica raccontando una verità; se è falso
che Pippo è socialista o che ha bruciato il quadriciclo è vero che lui e
Lillina se l'intendono. Le tracce erano sparse per il romanzo: la lettera
anonima, i viaggi a Fela. Questo rivela Sasà in una lettera, rigorosamente
firmata, al suocero del Genuardi. E la verità muta la commedia in dramma,
il classico dramma della gelosia, che si conclude con due morti.
Ma la verità non è destinata a trionfare. E se è vero che la vita in
Sicilia è "tiatro", a far "tiatro" è una volta ancora la Benemerita Arma
dei RR CC, attraverso l'appuntato Licalzi, siciliano, che "spiega" al
tenente come volgere le cose a loro vantaggio e dimostrare di aver sempre
avuto ragione. Di nuovo infatti i "carrabbinera" riescono a far passare il
Genuardi per un sovversivo, dichiarandolo morto per una bomba
incidentalmente scoppiatagli mentre la confezionava.
E' così che il Prefetto, persona psicologicamente ed intellettivamente
incapace, è gratificato con una promozione finale; il Questore e il
Delegato di pubblica sicurezza, persone competenti, ma evidentemente prive
di forza, per così dire "contrattuale", finiscono in Sardegna (che
chiaramente lo Stato considera a un livello più basso della Sicilia); i
Reali carabinieri, vero organismo di polizia di stato e che hanno agito
sempre secondo metodi mafiosi ricevono un Encomio Solenne e un graditissimo
trasferimento nella capitale.
Reali Carabinieri, Questore, Delegato, don Lollò sono i personaggi seri del
romanzo; tutti gli altri personaggi, anche il Genuardi e lo stesso don
Nené, uomo onesto ed equilibrato, sono descritti, almeno una volta in
atteggiamenti comici. Anche il dramma finale è filtrato nei toni della
commedia. Don Nenè è visto attraverso gli occhi della moglie Lillina, che,
non sapendo la causa del comportamento del marito, lo descrive come "pazzo,
i capiddri dritti, gli occhi sbaraccati". E l'unico personaggio che avrebbe
potuto esprimere dolore e solo dolore, la moglie del Genuardi e figlia di
don Nenè, e che è stata interprete nel romanzo sempre di episodi comici,
nel finale non è nominata.
A cura di Odeia
|