|
Negli anni che vanno dal 1909 al 1911 le referenze propriamente teatrali di Pirandello sono praticamente nulle. Un solo atto unico rappresentato, quel Lumie di Sicilia che Nino Martoglio inscena al «Teatro minimo» e che, paradossalmente, è assai meno pirandelliano di altri che compaiono nello stesso cartellone, ad esempio, di Maschere dovuto a Roberto Bracco, e due commedie nel limbo (o nell'inferno) del cassetto: l'atto unico La morsa e i tre atti di Se non così, in seguito più conosciuti col titolo La ragione degli altri. Ma al magro stato di servizio si oppone in quegli stessi anni la composizione e la pubblicazione di Suo marito, un romanzo che conobbe vicende perfino non letterarie ma che è anche e in particolar modo un romanzo teatrale. E non tanto perché largamente si occupa di due commedie (e che commedie! Coprono in effetti tutt'intero l'arco di un'esistenza creativa: si tratta di Se non così, già in parcheggio dal 1899, e della puntuale sceneggiatura d'una commedia a venire ben vent'anni dopo, La nuova colonia) ma soprattutto perché in quelle pagine si parla e si discute del « far teatro ». In questo senso, Suo marito è una sorta di manifesto del rifiuto, esso ci dona del teatro del primo decennio di questo secolo un'immagine in negativo, il cui positivo ancora non ci è dato di travedere se non in qualche linea essenziale desumibile dall'estremismo delle negazioni, dalla perentorietà dei rigetti.
Si inaugura, con Suo marito, quella strategia dell'irrisione che nella trilogia moltiplicherà la sua carica dirompente non per una maggiore messa a fuoco dell'oggetto polemico ma per l'avvenuta contestuale invenzione di una ragione non formale del rifiuto. Tutta la tipologia della fauna «attore» evidenziata nella trilogia altro non è che l'adattamento scenico di alcune pagine di Suo marito, solo che l'inerte nullità, lo squallore che emerge dal disegno narrativo, sulla scena viene virato col colore del grottesco: i comici che anche durante le
prove si dedicano a «pettegolezzi e piccinerie» e mostrano «svogliatezza e cascaggine»; la primattrice che «non sapeva neanche lei una parola della parte, passava innanzi alla buca del suggeritore e ripeteva meccanicamente, come tutti gli altri, le battute che quello, vociando e dando le indicazioni secondo le didascalie, leggeva nel copione»; e il caratterista che addirittura «baritoneggia»; e il capocomico-direttore che carica troppo la parte; e la povertà polverosa degli scenari; e la trasandata approssimazione dei costumi; e il mito onnipresente dell'interpretazione come risultato d'una improvvisazione momentanea:
- «Senta, signora Carmi, lei dovrebbe farmi un piacere: dovrebbe farmi sentire il ruggito della Spera all'ultimo atto, quando soffoca il figlio».
- «Ah, impossibile, caro mio! Quello deve nascere lì per lì. Voi scherzate? Mi lacererebbe la gola. E poi, se lo sento una volta, io stessa, anche fatto da me, addio! Lo ricopio alla rappresentazione. Mi verrebbe a freddo».
E durante le prove di Se non così, la seconda commedia che nel romanzo lo stesso capocomico, Revelli, mette in scena, il disagiato panorama non cambia, anzi vi si insinua un elemento nuovo e assai più inquietante.
«Giustino si rannicchiò in fondo al palco, nel buio, con le spalle a la parete attigua al palcoscenico, per non farsi scorgere dagli attori, di cui rimbombavano le voci nel teatro vuoto.
- «Oh signora, oh signora» - baritoneggiava al solito suo il Grimi, coprendo la voce fastidiosa del suggeritore - e vi par troppa codesta?»
- «Ma no, nessuna grazia, caro signore» - sorrideva la piccola Grassi con la sua vocetta tenera.
E il Revelli gridava:
- Più strascicato! più strascicato! «Ma noooo, ma nessuna grazia, amico»...
- Il secondo «ma» non c'è!
- E lei ce lo metta, oh perdio! E' naturale!»
E dunque l’obbligo del modello. L’adeguamento allo stereotipo «naturale», consente, autorizza e giustifica l’alterazione omologante del dialogo: sicchè, alla luce d’una lettura similare a quella del capocomico Revelli, anche Croce potè in perfetta buonafede asserire che Se non così altro non era che «un dramma dello stato civile», una variazione giacomettiana, per intenderci. Ma c’è di più, sempre nel romanzo. C’è la precisa contestazione ad una codificata accezione del «teatro», ambigua e sfuggente summa di stratificazioni, comportamenti, regole, usanze e perfino manie e superstizioni, disorganica, e nello stesso tempo ferrea, linea di condotta al cui sottrarsi scatta l’esorcismo del dissenso del pubblica e della critica, del terrore totemico degli attori, dello sghignazzo dei cosiddetti tecnici. Puntualmente, nella vita, e proprio per la messinscena di Se non così, Pirandello avrà l'amaro piacere della suffragazione dei fatti. Nel circostanziato racconto che nel romanzo Pirandello fa della commedia, in ogni passo viene privilegiato il dramma della moglie sterile, Ersilia Arciani, nei confronti di quello della feconda amante di suo marito, Elena Orgera; anzi, ad un certo punto, Pirandello scrive: «l'anima, e i modi, di Ersilia Arciani debbono così governare tutta l'opera, per necessità». Ma quale necessità? Necessità d'autore e non certo necessità «teatrale» se nella prima messinscena del lavoro, nel 1915, la presenza di Emma Gramatica, primattrice, nella parte di E lena Orgera, spostò completamente l'accento dalla figura della moglie su quella dell'amante, livellando la tragedia dell'irrazionalità dei sentimenti al dramma borghese della difesa di un «giusto» sentimento. E quando qualche anno dopo Pirandello si rivolgerà al più celebrato dei direttori artistici di allora nella speranza di una nuova messinscena che restituisse alla commedia la sua giusta ottica, Virgilio Talli rispose che l'esimio scrittore poteva forse dal suo punto di vista avere qualche ragione, ma che «teatralmente, la protagonista è l'amante e non la moglie sterile».
Per questi, e per altri temi che nel romanzo affiorano con vivezza, può apparire a prima vista senza tentennamenti un certo allineamento di Pirandello al fianco degli innovatori Boutet e Garavaglia ai quali si deve l'attività della «Stabile Romana del Teatro Argentina», e che del resto Pirandello conosceva e frequentava regolarmente. Nel periodo in cui viene composto Suo marito, la parabola di Eduardo Boutet è già giunta al termine, ma ci sono state, al Teatro Argentina, le messinscene memorabili del Giulio Cesare di Shakespeare (1905), dei Ventri dorati di Fabre (1906) e di La nave di D'Annunzio (1908): spettacoli in cui emersero, a concorde parere della critica, soprattutto due fatti. Il primo era che gli attori, i costumi, le scene, concorrevano tutti alla dimostrazione di un'idea-guida: che tutti gli elementi costitutivi, cioè, erano finalizzati se non alla dimostrazione di una tesi critica, almeno a una coerenza di lettura. L'altro fatto, e certamente quello che più colpì, era che nelle scenografie e nei costumi risultava evidente la ricerca di un «vero» che potesse essere trasferito dalla vita sulla scena senza eccessive mediazioni. Si lodò a lungo il fatto, ad esempio, che per la costruzione della «nave» dannunziana fosse stato chiamato tal Cupellini, mastrodascia autentico e calafato. Il «vero» da sostituire al «falso» della cartapesta, dunque, quel vero in nome del quale nel 1904 per mettere in scena La figlia di Iorio il pittore Michetti e Arnaldo Ferraguti battono i casolari della campagna abruzzese rastrellando arnesi di cucina, fiasche, arcolai; quel vero in nome del quale per La città morta e per Più che l'amore arrivano calchi da Micene e ruderi presi in prestito a musei; quel vero in nome del quale il direttore artistico Mario Fumagalli, dovendo inscenare nel 1905 La fiaccola sotto il moggio volle che il palazzo dei Di Sangro, che doveva apparire fatiscente, venisse circondato da scale e impalcature fatte costruire sul palcoscenico del milanese «Manzoni» da muratori veri. Ma qui, a mio avviso, la pirandelliana strategia dell'irrisione si estende nelle pagine del romanzo a questo culto del vero, applicato, per di più, alla poesia di D'Annunzio. Cos'ha a che fare quel vero da museo con la verità del teatro? Inutilmente Giustino Roncella si farà arrivare da Taranto fotografie, costumi, oggetti veri: l'osmosi non è possibile, nel contesto stoneranno, saranno perciò rifiutati o se accettati, per contrasto, sottolineeranno il falso indissolubile dalla presente condizione dell'attore e del teatro.
Non è una puntata polemica da sottovalutare: già nel 1909 Pirandello sente chiaramente che la disciplina della recitazione, la mitologia del vero, la cura del dettaglio, tutto ciò insomma che si demanda al direttore artistico non è che palliativo, alibi, rimando, dilazione: ma pur sentendolo chiaramente, Pirandello allora non sa e non può indicare la controparte. La controparte possibile allora sarà il regista che prepotentemente balza alla ribalta di Questa sera si recita a soggetto? Un esame, anche superficiale, non può lasciare dubbio alcuno: si tratta, coll'avvento del regista, della pura e semplice sostituzione di una mitologia oramai sorpassata con un'altra che possiede sì la forza della novità, ma come l'altra destinata alla sconfitta per l'inadeguatezza, l'improprietà, la non aderenza dell'ideologia sovrapposta alla profonda verità del fatto teatrale in sé. Ecco, se il capocomico fa ancora parte della struttura, il regista è già una sovrastruttura, una sovrastruttura che serve a disastrare ancora di più la struttura. Il regista, secondo Pirandello, così come a suo tempo aveva fatto il direttore-artistico e come a suo tempo ancora il capocomico, combatte in realtà una battaglia di retroguardia, crede di star conducendo una vera e propria guerra di liberazione e invece si trova invischiato in uno scontro di pattuglie, in una scaramuccia. E non solo perché le sue truppe si ostinano a negarsi al combattimento con altre armi che non siano quelle tradizionali, no, la verità è che il grosso dell'esercito da affrontare è intanto andato avanti indifferente, è lontanissimo all'orizzonte.
L'unica che sempre in quegli anni non perdette il contatto, e mirò giusto, e previde le mosse e le anticipò troppo forse, era la Duse, ma era straordinariamente sola e straordinariamente fraintesa, e poi Lei era davvero un teatro «altro», che non ammetteva più margine fra esperienza di vita ed esperienza scenica. «Isterismo femminile, crisi di passione, tutti questi piccoli capricci di piccole donne, banalità della vita quotidiana, in una parola il flusso e il riflusso del teatro europeo fra il 1870 e il 1900 non bastavano più per Eleonora Duse. Il suo spirito era destinato a qualcosa d'altro, qualcosa di meno banale, qualcosa di più eroico, una più nobile espressione di vita»: sono parole di Pirandello a proposito della Duse, e da esse si può capire come il caso Duse non entri mai nel panorama dei comici pirandelliani: vi entrerà a mio avviso, assai più tardi, con quella Contessa Ilse che ricorda assai più la nostra grande tragica che non l'attrice alla quale le cronache dell'epoca vollero fare riferimento. E dunque lo scacco del direttore e dei suoi comici di fronte ai sei personaggi, lo scacco degli attori di fronte all'irruzione della realtà in Ciascuno a suo modo, lo scacco di Hinkfuss che evreinoffianamente tenta l'impossibile eguaglianza teatro-vita, sono scacchi predestinati e inevitabili e non certo perché si voglia, attraverso questi fallimenti, ancora una volta sottolineare l'impossibilità della comunicazione. Mi pare che qui almeno per ciò che riguarda la trilogia, il problema dell'incomunicabilità non vi si rifranga, perché se esso debordasse sulla scena nella sua globalità e con tutti i suoi postulati, teatro certamente più non si avrebbe, la sua esistenza diventando un nonsenso. Nella trilogia c'è semmai, e continua, la denuncia di una inadeguatezza, di una carenza come stato, di una crisi d'espressione che nasce non tanto dai modi e dai mezzi dell'esprimersi quanto dalla cristallizzazione a cui il teatro è giunto attraverso una depistante suddivisione del rapporto scena-pubblico. Non è tanto la sprovvedutezza rutiniera degli attori che non sanno negarsi alla codificazione, non è tanto l'errata angolazione sotto cui si pongono artigianalmente il direttore e ambiziosamente il regista, è piuttosto il fatto che il teatro, nel tentativo di recuperare la sua essenza che è la sua destinazione, fatalmente è costretto a spiazzare il cosiddetto interprete da quel luogo privilegiato di esperienze privilegiate che è il palcoscenico, e a spostare il luogo dell'autentico evento teatrale verso la sua collocazione più propria, che è il pubblico.
E', mi pare, la più folgorante intuizione della trilogia, nella quale è possibile rinvenire la radice delle molteplici sperimentazioni dei nostri giorni: il palcoscenico, nella trilogia, è il luogo d'una metafora a volte frusta, a volte inaccessibile, il luogo di una funzione che nasce e si consuma interamente dentro la ribalta, dentro la quarta parete, il luogo dove si vanifica l'essenza del teatro. Il luogo teatrale vero, quello da cui l'evento si irradiava frantumandosi nella singola unità dello spettatore e poi si ricomponeva nel pubblico e tra il pubblico - una comunione, appunto - ora non è più «quel» palcoscenico e non è più nemmeno «il» palcoscenico, quel rialzo dove tutto si svolge davanti al pubblico. Basterà osservare come Pirandello muova alla riappropriazione di un altro spazio per convenire che nella trilogia una sapiente tattica dosa per gradi e parallelamente l'annientamento del luogo privilegiato. Nei Sei personaggi i personaggi appaiono dal fondo della sala preceduti dall'usciere del teatro e mentre questi va ad annunziarli al capocomico, essi «si saranno messi a seguirlo, a una certa distanza, un po' smarriti e perplessi, guardandosi attorno». Perciò è assolutamente falsificante qualsiasi superfetazione registica che questi personaggi faccia apparire direttamente sul palcoscenico attraverso trabocchetti, ascensori e simili. I personaggi entrano dalla sala perché altro non sono che una delegazione del pubblico (e qui sarei tentato d'insinuare che il misterioso autore che li ha creati possa avere una lontana parentela con un altro autore, quello di Calderòn, per intenderci): nell'esemplare e per tanti versi illuminante edizione scenica di Orazio Costa che i personaggi fossero una specie di delegazione del pubblico era sottolineato dalla scenografia che, sul palcoscenico, a specchio, riproduceva la sala del teatro dove lo spettacolo si stava svolgendo. Ma anche così facendo, a mio parere, veniva a mancare l'effetto d'infrazione che i personaggi compiono per il fatto solo che percorrono un cammino inedito (sala, corridoio, scaletta, palcoscenico) e che per i tre quarti di questo percorso ci sarà nello spettatore un inevitabile senso di disagio perché alla direttrice di marcia dei sei personaggi si oppone tutt'intero l'orientamento dell'architettura teatrale stessa. E' esattamente come se nel corso di una pagina a stampa ci imbattessimo, non per un errore ma per una precisa volontà dello scrittore, in un rigo scritto da destra a sinistra e quindi leggibile con una certa, e prevista, difficoltà. L'infrazione si ripete solo alla fine della commedia, quando la Figliastra ripercorrerà in senso inverso il cammino dal palcoscenico al fondo sala, ma intanto, e con effetti immediatamente incommensurabili, il cerchio magico del luogo privilegiato sarà stato rifiutato e infranto.
Tre anni dopo la rappresentazione dei Sei personaggi, con Ciascuno a suo modo l'acquisizione di uno spazio diverso è totale, metà dell'intera rappresentazione si finge svolta e improvvisata nei corridoi, nel foyer, ma non certo sul palcoscenico. Però l'infrazione più grave non è tanto questa, che è solo un logico corollario dell'infrazione già commessa nei Sei personaggi, è quella pericolosamente preannunciata nelle primissime righe della didascalia iniziale:
«La rappresentazione di questa commedia dovrebbe cominciare sulla strada o, più propriamente, sullo spiazzo davanti al teatro, con l'annunzio (gridato da due o tre strilloni) e la vendita d'un Giornale della sera appositamente composto su un foglio volante, di modo che possa figurare come un'edizione straordinaria, sul quale a grossi caratteri e bene in vista, fosse inserita questa indiscrezione in esemplare stile giornalistico: IL SUICIDIO DELLO SCULTORE LA VELA E LO SPETTACOLO DI QUESTA SERA, ecc.»
La didascalia prosegue descrivendo la prima azione teatrale, e questa veramente a soggetto perché il testo non indica battute, che si deve svolgere nei pressi del vero botteghino del teatro. E perciò per Pirandello la corretta edizione di Ciascuno a suo modo non può più accettare interamente lo spazio interno al teatro, adesso quale che sia, palcoscenico o no, spazio compreso dentro un perimetro sul quale pesa la dannazione del fallimento: gli «spiacevoli incidenti» ai quali il capocomico attribuisce l'impossibilità di continuare a far commedia si riducono in realtà ad un solo incidente e certamente spiacevolissimo e cioè, mi si perdoni la frase, che il teatro, dentro il teatro non può più starci dentro. O cangia luogo o muore per mancanza d'ossigeno, perché s'è fatto stretto, perché dentro non ci si respira più. Il tentativo di Hinkfuss è proprio quello di dare ossigeno («Vi pare, signori che possa più essere vita dove non si muove più nulla? dove tutto riposa in una perfetta quiete?»), ma ad ogni passo il regista impatterà o nelle regole del «teatrale» che inevitabilmente si ripropongono risorgendo dalle loro stesse ceneri, ceneri che il luogo teatrale detto teatro ammassa e nasconde nelle pieghe del sipario, nel buio del sottopalco, nelle listelle della graticcia, nei polmoni degli attori, o nell'impossibilità per l'attore di cimentarsi con un compito estraneo e diverso fermo restando l'ambiente che lo circonda e dove per secoli si è mosso lungo una rotta di sicurezza e secondo una prassi collaudatissima:
SAMPOGNETTA: Dico che io, così, senza sapere come sono entrato in casa, se nessuno è venuto ad aprirmi, dopo aver tanto picchiato alla porta...
IL DOTTOR HINKFUSS: Ancora? Daccapo?
SAMPOGNETTA: ... non riesco a morire, signor Direttore, mi viene da ridere, vedendo come tutti sono bravi, e non riesco a morire.
IL DOTTOR HINKFUSS: Ma che va più contando, adesso? Non s'era già data per avvenuta la sua entrata in casa?
SAMPOGNETTA: E allora scusi, tanto vale che mi dia anche per morto e non se ne parli più.
IL DOTTOR HINKFUSS: Nient'affatto! Lei deve parlare, far la scena, morire!
SAMPOGNETTA: E va bene! Ecco fatta la scena (s'abbandona sul divano): sono morto.
IL DOTTOR HINKFUSS: Ma non così!
SAMPOGNETTA: Caro signor Direttore, venga su e finisca d'ammazzarmi lei, che cosa vuole che le dica?
E appunto questo avverrà puntualmente qualche decina d'anni dopo. In quel luogo sempre più impraticabile, sempre più fortezza assediata, sempre più zattera della Medusa, tutte le possibili profezie di Pirandello si compiono. Il regista salirà sul palcoscenico e ucciderà l'attore che «non riusciva a morire». E qualche decennio ancora dopo l'attore deciderà che è meglio uccidere il regista piuttosto che imparare a morire. La lotta, che io sappia, ancora continua con alterne fortune, con i tradimenti inevitabili, con le sue stanchezze. E così l'autore a volte si toglie i gradi, e l'attore se li mette; altre volte attore e regista scoprono alleandosi che il nemico è un altro, il pubblico, e lo selezionano, lo torturano, lo terrorizzano. Il rito antropofagico però incontra sempre più vaste plaghe di disinteresse. Altri invece raccolsero l'invito alla fuga e si buttarono sulle strade e sulle piazze, tutto mettendo a rischio, talvolta perdendo identità e connotazioni; alla ricerca di «qualcosa di eroico, di una più nobile espressione di vita», per adoperare le stesse parole che Pirandello con cura e certo con amarezza scelse per Eleonora Duse. Più coraggiosi di quelli che sono rimasti dentro, o più vili di quelli che sono rimasti dentro, ancora non sappiamo. Ancora, a quasi cinquant'anni dall'ultima opera della trilogia, il problema lucidamente individuato e posto sul tappeto da Pirandello è tutto da dibattere, da soffrire.
Andrea Camilleri
Testo pubblicato nel volume La trilogia di Pirandello, a cura di Enzo Lauretta
Atti del Convegno Internazionale su "Il Teatro nel teatro di Pirandello"
Agrigento, 6-10 dicembre 1976
(Centro Nazionale di Studi Pirandelliani, Agrigento 1977, pp. 141-148).
Il testo è stato poi riproposto in Pirandello e il teatro, a cura di
E. Lauretta (Palumbo, Palermo 1985, pp. 371-378)
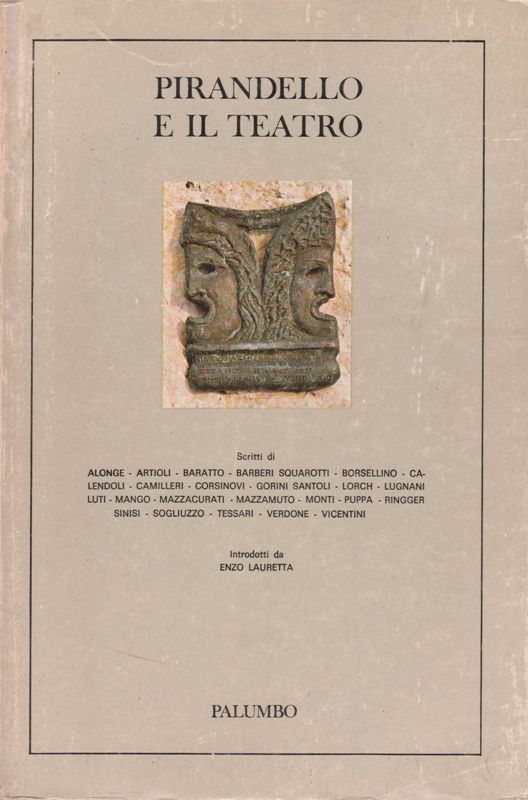
|




