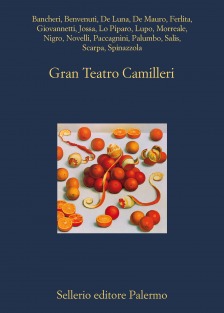|
Storici, critici, linguisti, filologi, antropologi, esperti della comunicazione, italianisti propongono una interpretazione del successo di Andrea Camilleri a partire dalla propria disciplina. Lo storico Giovanni De Luna, il linguista Tullio De Mauro, il critico Vittorio Spinazzola, curatore dell’annuario «Tirature», gli esperti di letteratura italiana contemporanea Ermanno Paccagnini e Mauro Novelli, il filosofo del linguaggio Franco Lo Piparo, oltre allo stesso Salvatore Silvano Nigro curatore del volume, sono solo alcuni degli specialisti chiamati a spiegare che scrittore è Andrea Camilleri e le ragioni della sua indiscussa e autentica popolarità.
Ma non si tratta solo di spiegare il fenomeno editoriale. Qui si scava più a fondo, si tratta di capire cosa sono i racconti di Camilleri - non importa se si tratta dei romanzi storici o della saga di Montalbano -, il suo rapporto con la storia, con la lingua, con i luoghi, con le abitudini e i riti della terra cui appartiene e in cui ambienta le sue storie, quali contenuti trasmette e con quali metodi.
Nell’anno dei 90 anni di Camilleri un omaggio allo scrittore, una chiave di lettura della sua opera.
Ha conosciuto Pirandello e ha fraternizzato con Sciascia. Ha percorso molto più di mezzo secolo di storia e di letteratura, chiamando attorno a sé l’orizzonte. Ha maniere cattivanti, sapide: da conversatore; e da maestro di cerimonie. Procede con il passo dell’avventura, tra avvisi vari di pericolosità sociale, di criminalità politica e di stoltezza governativa. Mostra e sbeffeggia i lati osceni della violenza privata e pubblica. Rende grottesca la ciarlataneria demagogica (di ieri e di oggi: col petto in fuori e mascella, sempre, a ferro di cavallo) o l’imbecillaggine dei marescialli dei regolamenti devoti all’accanimento burocratico. Fa schioccare le dita, ed ecco che ogni sua parola diventa un evento sonoro; ogni sua pagina un tripudio del linguaggio: una ribalta teatrale. Camilleri scavalca i generi letterari e le loro frigide regole. Predilige i contagi formali e mette tutto (cronaca, storia, ricerca erudita, pamphlet, saggismo, antropologia di riti e di ghiotte imbandigioni) in prosa di romanzo, con perfetta ingegneria: con leggerezza umoristica, malizia burlesca e tragicomica moralità. La vocazione topografica, alimentata da un magazzino di paesaggi, gli ha fatto costruire un brano di paese, che si spazializza con l’infallibile esattezza geometrica del suo distendersi nelle narrazioni attivate dalle indagini non proprio protocollari e dalle gag di un commissario che non finisce mai di far la punta al suo ingegno e ha il garbo domestico dell’uomo della porta accanto. Vigàta è un villaggio-mondo, provincia d’Italia, sempre lo stesso e sempre vario. Dentro il suo compatto organismo, condivide lingua e costumi, ludi e motteggi, tic mimici e tic verbali, slanci umani e suggestioni mafiose, memorie e genealogie, propensione alla recita e, quando capita, al deragliamento mentale. Di questo Gran Teatro, a variazioni sceniche, Camilleri ha fatto il suo regno.
I diciassette saggi, qui strutturati in volume, scendono nella sala macchine dell’imponente e prodigioso Teatro Camilleri, e organizzano persino escursioni stravaganti per le strade del fenomeno Montalbano e peripli attorno alle copertine dei romanzi. Sono guide d’autore, firmate, oltre che dal curatore, da Tullio De Mauro, Franco Lo Piparo, Giovanni De Luna, Giuliana Benvenuti, Giuseppe Lupo, Salvatore Ferlita, Salvatore Bancheri, Ermanno Paccagnini, Vittorio Spinazzola, Matteo Palumbo, Mauro Novelli, Emiliano Morreale, Paolo Giovannetti, Roberto Scarpa, Stefano Jossa, Stefano Salis.
Salvatore Silvano Nigro
Un pezzo da Novanta
Prefazione di Salvatore Silvano Nigro
Narratore come pochi, Andrea Camilleri è anche un evento: una festa per i lettori. Racconta delle storie. E con voce larga e fonda apre spazi scenici. I suoi romanzi sono voce su carta, pura rappresentazione: «teatri» ai quali assicura realtà di scorci, e sonorità, quella lingua d’invenzione che non è un incesto (filologico, chimico, accademico) di lingua e dialetto, ma la parlata felicemente viva e fluente nel mondo strutturato di Vigàta e nelle sue ordinarie recite all’improvviso: senza copioni e senza palchi. Camilleri si sgranchisce le gambe passeggiando liberamente nei campi aperti della letteratura, renitente alle regole che imporrebbero un colore specifico al genere di romanzo prescelto; e distinzione tra saggio storico, racconto, cronaca, denuncia, e pamphlet. Camilleri ha scelto l’indistinzione. Disorienta i generi letterari. Come storico, che dà forma narrativa alle sue indagini, frequenta gli anfratti poco cartografati dalla storiografia: i tanti
hic sunt leones della carta d’identità della nazione. Come cronista di Vigàta, scrive il giornale, il diario di bordo di una navigazione a vista dentro le disfunzioni, gli abusi, i crimini, le collusioni delinquenziali, le intimidazioni mafiose, la corruzione, le truffe, i guasti morali, politici, istituzionali, di un paese fin troppo reale dentro la finzione romanzesca.
C’è un momento, nella carriera di Camilleri scrittore, che è decisivo per il riconoscimento della sua particolare vena narrativa; e soprattutto per l’inserimento della sua prosa comunque storica nella tradizione che da Manzoni arriva all’attualizzazione civile di Leonardo Sciascia. La svolta ha una data precisa: il 1984. È l’anno in cui Sciascia officia il rito d’accoglimento di Camilleri in questa continuità di progettazione letteraria, sancendone l’appartenenza di diritto al laboratorio editoriale da lui predisposto a Palermo, insieme a Elvira e Enzo Sellerio.
Sciascia prese in mano il dattiloscritto del risvolto redazionale che doveva scortare
La strage dimenticata di Andrea Camilleri. Lesse: «Alla fine di questo libro sono elencati centoquattordici nomi che non compaiono in nessuna lapide del nostro risorgimento, centoquattordici caduti della rivoluzione del 1848 in Sicilia. “Servi di pena” –com’erano chiamati i galeotti nelle carte burocratiche del tempo a registrazione dei servigi resi dal lavoro coatto– uccisi dalla polizia borbonica non per colpe particolari né perché rappresentavano un pericolo reale. Le autorità, quelle borboniche e quelle unitarie, ad arte ne confusero e occultarono la sorte, e nessuno storico si è mai occupato di loro. Gli assassini e i complici silenziosi compirono la loro riverita carriera di notabili, sotto i borboni, prima, e poi nell’Italia unitaria, e forse su di un muro sperduto o in qualche cascina una lapide la onora.
Digressioni per una doppia strage riesuma dall’oblio quei nomi, rintraccia gli assassini, ricostruisce i moventi. Ci rammenta, una volta ancora, come sia più “maestra” la storia che cerca le lapidi che nessuno ha mai messo».
In capo al foglio, Elvira Sellerio aveva scritto di suo pugno il titolo che Camilleri aveva proposto per il romanzo:
Digressioni per una doppia strage. Sciascia scelse un titolo meno affiochito, più centrato, e di maggiore secchezza emotiva. Scrisse:
La strage dimenticata. Si immerse poi nel risvolto. Intervenne sul testo di copertina. Lavorò di precisione: i «centoquattordici caduti della rivoluzione del 1848» diventò i «centoquattordici caduti nella rivolta del 1848». Eliminò «compirono», sostituito con «fecero». Semplificò, dove necessario, l’articolazione delle frasi. Dischiuse la sintassi narrativa, con qualche breve aggiunta di puntualizzazione: la polizia borbonica uccise i «servi di pena», pur non temendo nessun «pericolo» preciso, «se non quello, forse,» –aggiunse– «che si associassero agli insorti». Mise a fuoco, soprattutto, la congiura della cattiva coscienza politica che accomunò, nel tempo, governo borbonico e stato unitario. Il redattore aveva semplicemente fatto cenno all’occultamento «ad arte» della strage, nella Sicilia borbonica dapprima, e in quella risorgimentale dopo. Sciascia disciolse quell’«arte» nell’acido corrosivo del giudizio, e tradusse: «per diversa responsabilità e per uguale malafede». A conclusione, fece seguire una più incisiva riformulazione dell’ideologia delle lapidi: «La strage dimenticata trae dall’oblio quei nomi, rintraccia gli assassini, ricostruisce i moventi. Ci rammenta, una volta ancora, come sia più “maestra” di quella delle lapidi la storia che cerca le acri, tragiche ed umili verità».
Goffredo Parise diceva che quella del risvolto è un’arte «dell’indicazione». E non c’è dubbio. Sciascia gestì con affabilità la sua lettura dell’opera di Camilleri in modo da indirizzarla, com’era sottinteso nella scrittura stessa del libretto, verso la polemica manzoniana contro la letteratura che monumentalizza la verità per adulterarla e seppellirla nel marmo delle versioni ufficiali. Manzoni aveva fatto seguire ai
Promessi Sposi la Storia della Colonna infame per svelare l’infamia di un monumento (la Colonna con lapide annessa) e di un’arrogante menzogna politica; e per rivelare, con il suggerimento di una lettura retroversa del suo romanzo (dalla
Colonna ai Promessi), quante «acri, tragiche ed umili verità» storiche possano disseppellire e trasmettere l’ironia e il sarcasmo di una scrittura romanzesca.
Sciascia aveva maturato la sua idea di letteratura civile alla scuola del Manzoni della
Colonna infame. E nel costruire e indirizzare congenialmente il laboratorio della casa
editrice Sellerio, aveva voluto salutare e marcare il manzonismo civile di un «giovane» scrittore
che sarebbe cresciuto dentro il catalogo che lui andava costruendo. Camilleri aveva allora poco meno
di sessant'anni. Non era anagraficamente giovane. Ma per gli annali della letteratura, era quasi un
esordiente inattesa di successo.
Adesso Camilleri compie novant'anni. Troneggia nel catalogo Sellerio. E con il suo
successo «planetario»
salva (lo suggerisce Alberto Asor Rosa, nel recente saggio Scrittori e massa) le classifiche
dei libri più venduti, assicurando ad esse quel «rispetto»
che altrimenti on avrebbero.
Dal profondo del suo catalogo la casa editrice Sellerio fa gli auguri al suo «giovane» autore,
appena trentacinquenne. E attorno a lui raccoglie, per festeggiarlo, amici e studiosi.
(Il testo sopra riportato è stato pubblicato su
Domenica - Il Sole 24 Ore del 30 agosto 2015)
L'«àccipe» e il colibrì: linguaggio ed ethos di Andrea Camilleri
Conclusione dell'intervento di Tullio De Mauro
[...]
Narratore come pochi, Andrea Camilleri è anche un evento: una festa per i lettori. Racconta delle storie. E con voce larga e fonda apre spazi scenici. I suoi romanzi sono voce su carta, pura rappresentazione: «teatri» ai quali assicura realtà di scorci, e sonorità, quella lingua d’invenzione che non è un incesto (filologico, chimico, accademico) di lingua e dialetto, ma la parlata felicemente viva e fluente nel mondo strutturato di Vigàta e nelle sue ordinarie recite all’improvviso: senza copioni e senza palchi. Camilleri si sgranchisce le gambe passeggiando liberamente nei campi aperti della letteratura, renitente alle regole che imporrebbero un colore specifico al genere di romanzo prescelto; e distinzione tra saggio storico, racconto, cronaca, denuncia, e pamphlet. Camilleri ha scelto l’indistinzione. Disorienta i generi letterari. Come storico, che dà forma narrativa alle sue indagini, frequenta gli anfratti poco cartografati dalla storiografia: i tanti
hic sunt leones della carta d’identità della nazione. Come cronista di Vigàta, scrive il giornale, il diario di bordo di una navigazione a vista dentro le disfunzioni, gli abusi, i crimini, le collusioni delinquenziali, le intimidazioni mafiose, la corruzione, le truffe, i guasti morali, politici, istituzionali, di un paese fin troppo reale dentro la finzione romanzesca.
C’è un momento, nella carriera di Camilleri scrittore, che è decisivo per il riconoscimento della sua particolare vena narrativa; e soprattutto per l’inserimento della sua prosa comunque storica nella tradizione che da Manzoni arriva all’attualizzazione civile di Leonardo Sciascia. La svolta ha una data precisa: il 1984. È l’anno in cui Sciascia officia il rito d’accoglimento di Camilleri in questa continuità di progettazione letteraria, sancendone l’appartenenza di diritto al laboratorio editoriale da lui predisposto a Palermo, insieme a Elvira e Enzo Sellerio.
Sciascia prese in mano il dattiloscritto del risvolto redazionale che doveva scortare
La strage dimenticata di Andrea Camilleri. Lesse: «Alla fine di questo libro sono elencati centoquattordici nomi che non compaiono in nessuna lapide del nostro risorgimento, centoquattordici caduti della rivoluzione del 1848 in Sicilia. “Servi di pena” –com’erano chiamati i galeotti nelle carte burocratiche del tempo a registrazione dei servigi resi dal lavoro coatto– uccisi dalla polizia borbonica non per colpe particolari né perché rappresentavano un pericolo reale. Le autorità, quelle borboniche e quelle unitarie, ad arte ne confusero e occultarono la sorte, e nessuno storico si è mai occupato di loro. Gli assassini e i complici silenziosi compirono la loro riverita carriera di notabili, sotto i borboni, prima, e poi nell’Italia unitaria, e forse su di un muro sperduto o in qualche cascina una lapide la onora.
Digressioni per una doppia strage riesuma dall’oblio quei nomi, rintraccia gli assassini, ricostruisce i moventi. Ci rammenta, una volta ancora, come sia più “maestra” la storia che cerca le lapidi che nessuno ha mai messo».
In capo al foglio, Elvira Sellerio aveva scritto di suo pugno il titolo che Camilleri aveva proposto per il romanzo:
Digressioni per una doppia strage. Sciascia scelse un titolo meno affiochito, più centrato, e di maggiore secchezza emotiva. Scrisse:
La strage dimenticata. Si immerse poi nel risvolto. Intervenne sul testo di copertina. Lavorò di precisione: i «centoquattordici caduti della rivoluzione del 1848» diventò i «centoquattordici caduti nella rivolta del 1848». Eliminò «compirono», sostituito con «fecero». Semplificò, dove necessario, l’articolazione delle frasi. Dischiuse la sintassi narrativa, con qualche breve aggiunta di puntualizzazione: la polizia borbonica uccise i «servi di pena», pur non temendo nessun «pericolo» preciso, «se non quello, forse,» –aggiunse– «che si associassero agli insorti». Mise a fuoco, soprattutto, la congiura della cattiva coscienza politica che accomunò, nel tempo, governo borbonico e stato unitario. Il redattore aveva semplicemente fatto cenno all’occultamento «ad arte» della strage, nella Sicilia borbonica dapprima, e in quella risorgimentale dopo. Sciascia disciolse quell’«arte» nell’acido corrosivo del giudizio, e tradusse: «per diversa responsabilità e per uguale malafede». A conclusione, fece seguire una più incisiva riformulazione dell’ideologia delle lapidi: «La strage dimenticata trae dall’oblio quei nomi, rintraccia gli assassini, ricostruisce i moventi. Ci rammenta, una volta ancora, come sia più “maestra” di quella delle lapidi la storia che cerca le acri, tragiche ed umili verità».
Goffredo Parise diceva che quella del risvolto è un’arte «dell’indicazione». E non c’è dubbio. Sciascia gestì con affabilità la sua lettura dell’opera di Camilleri in modo da indirizzarla, com’era sottinteso nella scrittura stessa del libretto, verso la polemica manzoniana contro la letteratura che monumentalizza la verità per adulterarla e seppellirla nel marmo delle versioni ufficiali. Manzoni aveva fatto seguire ai
Promessi Sposi la Storia della Colonna infame per svelare l’infamia di un monumento (la Colonna con lapide annessa) e di un’arrogante menzogna politica; e per rivelare, con il suggerimento di una lettura retroversa del suo romanzo (dalla
Colonna ai Promessi), quante «acri, tragiche ed umili verità» storiche possano disseppellire e trasmettere l’ironia e il sarcasmo di una scrittura romanzesca.
Sciascia aveva maturato la sua idea di letteratura civile alla scuola del Manzoni della
Colonna infame. E nel costruire e indirizzare congenialmente il laboratorio della casa
editrice Sellerio, aveva voluto salutare e marcare il manzonismo civile di un «giovane» scrittore
che sarebbe cresciuto dentro il catalogo che lui andava costruendo. Camilleri aveva allora poco meno
di sessant'anni. Non era anagraficamente giovane. Ma per gli annali della letteratura, era quasi un
esordiente inattesa di successo.
Adesso Camilleri compie novant'anni. Troneggia nel catalogo Sellerio. E con il suo
successo «planetario»
salva (lo suggerisce Alberto Asor Rosa, nel recente saggio Scrittori e massa) le classifiche
dei libri più venduti, assicurando ad esse quel «rispetto»
che altrimenti on avrebbero.
Dal profondo del suo catalogo la casa editrice Sellerio fa gli auguri al suo «giovane» autore,
appena trentacinquenne. E attorno a lui raccoglie, per festeggiarlo, amici e studiosi.
(Il testo sopra riportato è stato pubblicato su
La Repubblica (ed. di Palermo) del 4 settembre 2015)
Testimone (scomodo) del ventennio berlusconiano
Dall'intervento di Giovanni De Luna
I due decenni dell’era berlusconiana sono stati scanditi dai libri di Andrea Camilleri, in un profluvio di titoli che dal 1992 (La stagione della caccia) al 2011 (La setta degli angeli) ha fatto registrare l’uscita di più di 50 volumi: tutti, quelli che hanno Montalbano come protagonista ma anche quelli «storici» che raccontano la Sicilia della seconda metà dell’Ottocento o gli anni del fascismo, ci parlano del presente in cui sono stati scritti. Si è stratificato così un gigantesco giacimento documentario e archivistico al quale lo storico del futuro potrà attingere quando vorrà studiare lo spirito di questo tempo. Grazie al loro successo e all’ampiezza e alla varietà del pubblico dei lettori di Camilleri, c’è infatti nei suoi libri la capacità di rispecchiare quell’insieme di scelte, comportamenti, bisogni, emozioni che definiscono l’esistenza collettiva di un paese. Ma c’è, soprattutto, la loro efficacia nell’aiutarci a penetrare nelle profondità del rapporto tra realtà e rappresentazione della realtà, svelandone la finzione, abituandoci a una consapevolezza critica da usare come antidoto nei confronti di mitologie che appartengono oggi al mercato e ai media, così come in passato appartenevano ai regimi totalitari.
«Puzza di teatro»
In tutti i romanzi di Camilleri c’è «puzza di teatro». Quella della messa in scena è la tecnica narrativa che lo definisce come scrittore, e probabilmente i suoi libri sarebbero stati scritti comunque in quella forma anche in un altro tempo. E le messe in scena caratterizzano in modo decisivo la politica di oggi; di qui la consapevolezza che il suo modo di raccontare riproduca l’essenza stessa di questo tempo, in un contesto in cui - che si parli del delitto di Cogne o delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein - la realtà, per essere seduttiva e convincente, non ha più bisogno di essere vera: «E così», scriveva sulla
Stampa il 16 novembre 2005, «in questo grande, frastornante teatro mediatico, ha finito col non contare più la ricerca di una verità, sia pure una verità processuale, mentre è diventata essenziale la momentanea vittoria degli innocentisti sui colpevolisti e viceversa». Il riferimento era al
Porta a porta di Bruno Vespa, ma anche alla «rappresentazione» orchestrata dagli Stati Uniti in piena Assemblea dell’Onu per convincere il mondo della necessità della guerra contro l’Iraq. Sia in questo sia in tutti gli altri articoli sulla
Stampa, sia con Montalbano sia nei romanzi storici, Camilleri ha dunque raccontato l’Italia degli ultimi venti anni aiutandoci a squarciare il velo dell’impostura spesso utilizzata dal potere politico per consolidare una legittimazione sempre precaria.
Senza «tragediature»
Lo ha fatto con il suo «metodo», percorrendo strade consolidate che il lettore ha imparato a riconoscere e ad amare: la storia rappresentata a «tinte gialle», come un’indagine per smascherare gli inganni e le ingiustizie; un appiglio, un documento di partenza, un volantino, un decreto, un’inchiesta parlamentare, il frammento di un libro; una vicenda avventurosa, intessuta di elementi fantastico-meravigliosi, in grado di rompere la crosta della quotidianità; un potere che reclama le sue vittime, in una visione mai rassicurante o consolatoria; un pessimismo dolente che investe le fondamenta stesse del rapporto tra politica e società civile, senza sconti per nessuna delle due. [...]
Ma lo ha fatto anche in maniera esplicita, senza «tragediature»: «Io sono tutto dalla parte di Chevalley», scrisse ancora sulla
Stampa a proposito delle sue riflessioni sulla Sicilia della seconda metà dell’Ottocento. E lo sguardo sulla sua isola esprime più il disagio che il compiacimento: «La mia Sicilia non è terra rassegnata e sonnolenta… è costantemente in movimento, in rivolta contro qualcosa o qualcuno. Che poi io racconti queste vicende in modo ironico o che possa far scivolare il lettore in un’aperta risata, questo non significa né mancanza di passione e ancora meno assenza di passione civile: è un modo, appunto civile, di esporre problemi molto seri». [...]
«Preferirei di no».
«Ogni tanto mi indigno… mi è successo qualche volta con Berlusconi», confessò quasi con timidezza a Marcello Sorgi, insistendo anche su una sorta di disincanto rispetto alle ragioni di un’opposizione antiberlusconiana spesso troppo carica di indignazione per essere lucida ed efficace. Per contrastare le grida scomposte e gli schiamazzi che per venti anni hanno riempito di umori tanto bellicosi quanto effimeri lo spazio della politica italiana, Camilleri ha scelto un altro tono, meno sopra le righe. Vi ricordate il «preferirei di no» dei 12 professori universitari che rifiutarono di giurare fedeltà al fascismo? Si era nel 1931. Su 1200 professori, solo 12 ebbero il coraggio di rifiutare il giuramento e quei 12 si ritrovarono a fare i conti con un fascismo trionfante, che non mancò di deriderli, giudicandoli poco più che un piccolo gruppo di folli.
Restarono soli i «12 che non giurarono». Si scontrarono frontalmente con la politica dello Stato totalitario, ma non trovarono nessun conforto nemmeno nella politica degli altri, negli ambienti «ufficiali» dell’antifascismo. Benedetto Croce consigliò a tutti di giurare perché «era meglio che continuassero a insegnare per mantenere viva la cultura democratica». Furono quindi soli con sé stessi. Eppure rifiutarono. Nessuno di loro colse l’occasione per urlare il proprio antifascismo; e quel tono leggero, quasi dimesso, fu lo schiaffo più clamoroso scagliato contro il fascismo trionfante di quegli anni.
(Il testo sopra riportato è stato pubblicato su
La Stampa del 6 settembre 2015)
|