|
Le parentesi di Guglielmi
Nel
Devoto-Oli della voce “Parentesi” si forniscono due definizioni. La prima,
quella che ci riguarda, dice: “Quanto
si interpone nel discorso, interrompendone formalmente la continuità per lo
più a scopo di chiarimento o di precisazione”.
Come si vede, Devoto e
Oli vanno subito al sodo, cioè indicano come prima cosa non la forma grafica
della parentesi, ma quello che essa in genere contiene (“quanto”), ossia
un chiarimento o una precisazione. Se vado in cerca di qualcosa di più
specialistico e apro il Dizionario di
retorica e di stilistica di Angelo Marchese alla voce “Parentesi”
trovo:
Segno grafico che
racchiude un termine o una frase incidentale.
V.
INCISO
E andiamo a guardare
“Inciso”:
Termine o
enunciato (in tal caso si parla di frase incidentale o parentetica) incastrato
in una proposizione reggente, senza alcun rapporto di subordinazione.
E quindi, di seguito, un
esplicativo esempio manzoniano:
Don Abbondio (il
lettore se n’è già accorto) non era nato con un cuor di leone.
Ahi. C’è qualcosa che
non torna in quest’esempio rispetto alla definizione di Devoto-Oli. Perché
il fatto che il lettore si sia già accorto della avidità di Don Abbondio non
è né un chiarimento né una precisazione del carattere del personaggio. La
parentesi della frase manzoniana può essere benissimo cancellata senza che la
proposizione reggente ne subisca la benché minima alterazione, quella
parentesi è talmente priva di subordinazione da risultare quasi
insubordinata. Perché dunque Manzoni ha messo quella parentesi? Perché in
realtà per tutto il romanzo ha con il lettore un rapporto di colloquio
diretto, a tu per tu, fino alle righe finali, e questo rapporto ogni tanto
viene richiamato nel corso del racconto. Quindi questa parentesi obbedisce ad
un’altra necessità, del tutto narrativa, che non rientra né nei
chiarimenti né nelle precisazioni.
Allora la domanda è: da
quale necessità nascono le parentesi che Angelo Guglielmi, da un certo
momento in poi della sua attività, ha cominciato a disseminare nelle note
critiche che pubblica su quotidiani e riviste?
Anzitutto va notato che
se in alcuni articoli le parentesi sono relativamente poche, in altri invece
sono così tante da quasi controbilanciare le frasi non parentetiche. Ma
attenzione: l’infittirsi delle parentesi non è quasi mai in rapporto alla
difficoltà, alla problematicità oggettiva di un dato testo, alla sua
complessità, il che sarebbe in un certo senso spiegabile. E allora? Allora la
cosa migliore da fare è andare a rileggere la recensione di Guglielmi di un
libro da me ben conosciuto e cercare di capire che cosa significhino le
parentesi. Piglio ad esempio, solo a scanso di equivoci e di complicazioni,
non certo per esibizionismo, quello che scrisse su “L’Espresso” del 2
luglio 1998, a proposito del mio romanzo La
concessione del telefono. L’articolo, di una quarantina di righe estese
su quasi due colonne, ma molto spazio lo ruba una mia foto, contiene undici
parentesi che racchiudono o semplici parole o frasi più o meno lunghe. Ne
citerò qualcuna. Scrive Guglielmi:
E’ che Camilleri
è uno scrittore siciliano e siciliano vuole rimanere. Sciascia si fa
francese, Vittorini milanese, Camilleri come Pirandello vuole rimanere (e
rimane) siciliano.
La seconda frase sarebbe
una quasi inutile ripetizione della prima se non fosse per quella parentesi (e
rimane) che allarga il discorso, dando una risposta affermativa, da
critico, al desiderio dello scrittore che non sa quanto questo suo desiderio
sia realizzato. Però, pur essendo la risposta affermativa, Guglielmi non
fornisce la ragioni critiche che lo portano a quella conclusione. Si limita a
una dichiarazione, a una sorta di certificazione tranquillizzante per
l’autore. Un altro esempio:
…i siciliani
sono oppressi (assediati) da una realtà e da una natura forte e prepotente
che mentre accettano (e di esse non potrebbero fare a meno) pure sentono il
bisogno di distanziare.
Quell’assediati
contenuto nella prima parentesi evidentemente non è una precisazione e
tantomeno un chiarimento di oppressi.
Assediati e oppressi non sono sinonimi. L’oppressione è una schiavitù o
una cappa di piombo, l’assedio è un accerchiamento o un isolamento. La
parentesi, in questo caso, è come una leggera correzione di tiro, dovuta a un
ragionamento del critico il cui percorso, anche qui, non ci viene rivelato.
Più complesso il
discorso sulla seconda parentesi. Gli scrittori siciliani, secondo Guglielmi,
non solo accettano una realtà che pur si presenta sub specie di assedio o
d’oppressione, ma, e qui entra in gioco la parentesi, di essa non potrebbero
fare a meno. Quale “persona informata dei fatti” mi sono sentito, e mi
sento ancora rileggendole, assolutamente allo scoperto da quelle parole tra
parentesi. Quella parentesi di appena otto parole o quello che sono, dice
tutto di tutta la letteratura siciliana, con un’acutezza, con una profondità,
con un’intelligenza e con una semplicità assolute. E’ un saggio esaustivo
di una sola riga.
Guglielmi illustra
compiutamente la condizione naturale dello scrittore siciliano: da una parte,
l’accettazione della realtà opprimente o assediante che infine si rileva
elemento indispensabile, conditio sine qua non per la sua stessa esistenza, e
dall’altra parte la sua capacità di dar voce al bisogno di distanziarsene.
Senza questa presa di distanza, continua Guglielmi nel suo articolo, lo
scrittore siciliano rischia di essere travolto da quella realtà. E tra i
tanti modi di presa di distanza, Guglielmi cita la messa in dubbio dell’unicità
del reale offrendolo a ogni tipo di sospetto (di incertezza),
che è la strategia di Pirandello, e l’uso dell’ironia quale difesa massima, che è invece il mio caso.
Faccio un ultimo
esempio:
Così con “La
concessione del telefono” Camilleri ci propone un romanzo epistolare
(struttura già adatta al racconto d’amore) in cui, con forzatura geniale,
sviluppa una feroce (ma irresistibile) satira…
Lasciamo perdere la
prima parentesi che è solo una puntualizzazione.
Ma la seconda parentesi
perché c’è? Più semplicemente Guglielmi avrebbe potuto scrivere:
…sviluppa una
feroce, ma irresistibile, satira…
e invece si preoccupa di
mettere tra parentesi l’irresistibilità di questa satira. Anche qui la
parentesi evidentemente rimanda a un discorso taciuto.
In conclusione: le
parentesi insomma sono come quelle inserzioni giudiziarie a pagamento che si
vedono sui quotidiani e che riportano il dispositivo di una sentenza. La quale
sentenza, di condanna o di assoluzione, viene preceduta dal regolamentare
omissis che omette appunto tutto il lavorìo che ha preceduto e che infine ha
portato a quella conclusione. Ma quel lavorìo, indubbiamente, c’è stato.
Ecco: le parentesi di
Guglielmi, nella quasi totalità, non sono chiarimenti o precisazioni. Sono il momento
terminale di un processo mentale parallelo da parte del critico, terminale ma
non conclusivo perché il processo potrebbe ancora continuare e non è detto
che nuove acquisizioni non possano condurre a un risultato diverso.
Guglielmi disegna un suo
percorso principale all’interno di un testo, ma contemporaneamente si
affretta a tracciare, con le sue parentesi, numerosissimi sentieri, a volte
paralleli, più spesso alternativi e forse in grado di ribaltare il paesaggio.
E’ una dimostrazione, tra l’altro, di rarissima onestà critica.
Andrea Camilleri
(Scritto pubblicato su
Panta n.23/2004, Blob Guglielmi) 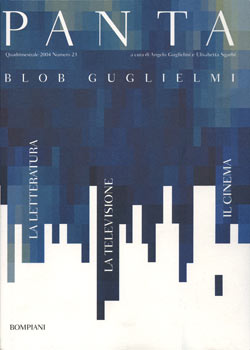
Questo
numero di "Panta", dedicato ad Angelo Guglielmi,
si presenta come un'occasione per rimeditare tre
fasi cruciali della cultura italiana del Novecento. Da una
parte le esperienze d'avanguardia della letteratura, in particolare col Gruppo
'63, di cui Guglielmi fu tra i fondatori,
ricordate da Alberto Arbasino e Andrea Camilleri.
Dall'altra, l'avventura televisiva di Rai Tre, con le trasmissioni
rivoluzionarie di Enrico Ghezzi
e Gianni Riotta. Ma Guglielmi
è stato anche direttore dell'Istituto Luce, in una fase di recupero
programmatico di celebri film italiani che un accurato restauro ha salvato
dall'oblio e dall'incuria. Letteratura, cinema e televisione, dunque, nel loro
intreccio e nel racconto di alcuni protagonisti
legati ad Angelo Guglielmi. |



