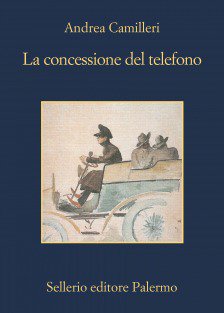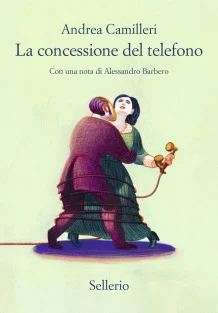|
Con una Nota di Alessandro Barbero e uno
scritto di Raffaele La Capria
«Camilleri scriveva perché si divertiva: ed è evidente che scrivendo La concessione del telefono si è divertito molto. E con lui si diverte il lettore, continuamente accompagnato dall’ironia dell’autore e dagli snodi via via più esilaranti di una classica commedia degli equivoci. Ma il divertissement non fa solo ridere, anzi, a un certo punto rischia di non far più ridere per nulla. Via via che si procede diventa fin troppo evidente che dietro c’è di peggio; c’è l’eterno dramma della burocrazia italiana, ma soprattutto un pessimismo millenario che dà per scontato che le cose cominciate male finiranno peggio, che chi prova a portare tra i pazzi un minimo di razionalità e di buon senso finirà stritolato, che ogni sistema premia i peggiori».
Alessandro Barbero
«Io credo che il romanzo italiano contemporaneo abbia in Andrea Camilleri uno dei suoi rappresentanti più notevoli ed originali, per la sua capacità di dominare con un colpo d’occhio tutta la commedia umana della sua Sicilia senza mai scadere nel bozzetto e nel costume; per le trame che sa far proliferare nel racconto mantenendo sempre la stessa tensione narrativa; per la implicita e mai superficiale critica sociale che si nasconde dietro le sue “storie naturali”. Si cominci a leggere questo suo romanzo semiepistolare per convincersene e sono sicuro che dopo averlo letto si cercheranno gli altri romanzi da lui scritti, soprattutto quelli legati a quest’ultimo, che si svolgono ognuno nello stesso paesino di Vigàta, nella Sicilia fine Ottocento, dando vita a una vera e propria saga isolana. E non si dimentichi che Camilleri è nato a Porto Empedocle, in zona Pirandello».
Raffaele La Capria
Un delitto avrà luogo
Vigàta, Montelusa,
Fela, Fiacca… Sentendo questi nomi chiunque pensa subito una cosa, e una cosa
soltanto: siamo nel territorio del commissario Montalbano. Che nella produzione
di Andrea Camilleri siano numerosi anche i romanzi ambientati negli stessi
luoghi, ma alla fine dell’Ottocento anziché ai giorni nostri, molti lettori
ovviamente lo sanno; ma che quella toponomastica immaginaria e quella lingua
d’invenzione non siano affatto nate come lo scenario e il mezzo espressivo delle
avventure del commissario, anzi predatino la sua nascita (appaiono in Un filo
di fumo, del 1980; il primo romanzo con Montalbano è La forma dell’acqua,
del 1994), non molti lo immaginano. Anzi, quando lo scopri può sembrarti
straniante. Per dirla tutta, a me tanti anni fa, quando m’ero appena innamorato
della serie di Montalbano, parve innaturale e addirittura urtante già il solo
fatto che l’autore si permettesse di scrivere anche (anche!) dei romanzi
storici, invece di concentrarsi sull’unica cosa che interessava ai suoi lettori.
Bisogna capire il
contesto per scusarmi. Erano gli anni Novanta, e abitavo in una piccola città in
cui c’erano delle ottime librerie (e ci sono tuttora; non più, però, quella dove
ho scoperto Camilleri). I librai erano giovani e competenti, fratello e sorella;
e quando non sapevo più cosa leggere mi capitava di entrare da loro e chiedere,
a lei, un suggerimento. E una volta mi disse: guarda, c’è questo nuovo autore di
gialli che escono da Sellerio, io li ho letti e mi sono piaciuti molto. Uscii
con La voce del violino e Il cane di terracotta, e non molto dopo
tornai a chiedere tutti gli altri; e siccome ero ingenuo e superficiale, la
prima volta che tornato a casa aprii il preziosissimo libriccino blu e scoprii
che non c’era Montalbano e si trattava invece di un romanzo storico, ambientato
nell’Italietta provinciale dopo l’Unità (poteva essere Il birraio di Preston
come La stagione della caccia), ci rimasi malissimo, mi pareva
d’essere stato truffato. Camilleri, m’immagino, lo sapeva che certi lettori
reagivano così, e uno dei motivi per cui alla fine Montalbano gli faceva girare
i cabasisi è proprio la totale identificazione della sua produzione letteraria
con quell’unica, ancorché benedetta, creatura.
Adesso non starò a
dire che le opere più felici del Maestro sono proprio quelle ambientate nella
Vigàta ottocentesca, anziché quelle troppo fortunate ambientate ai tempi nostri,
perché sospetto che sia quello che pensano e dicono tutti i bas-bleu, gli
stessi secondo i quali Simenon passerà alla storia della letteratura per i libri
in cui non c’è Maigret; però la tesi non sarebbe difficile da sostenere. E
basterebbe questo piccolo capolavoro che avete in mano, La concessione del
telefono, per argomentarlo. Il libro è del 1998, e già intorno a questa data
vale la pena di fare qualche considerazione: nato nel 1925, Camilleri aveva già
alle spalle una carriera di regista teatrale e di regista e produttore RAI
quando pubblicò, nel 1978, il suo primo libro, Il corso delle cose; per
il secondo bisogna aspettare il 1980; per il terzo, il 1984. E poi arrivano i
miracolosi (per lui, dico) anni Novanta, in cui escono nove romanzi, quattro con
Montalbano e cinque senza, e tutti belli o bellissimi (qui volevo aggiungere
“almeno a parere di chi scrive”, ma poi ci ho ripensato: voglio vedere chi
direbbe il contrario). La concessione del telefono arriva dopo quattro
Montalbano consecutivi, più i racconti di Un mese con Montalbano – e in
quest’ultimo caso c’è già una spia rivelatrice: per la prima volta Montalbano è
nel titolo, spia sicura dell’enorme successo della serie. E proprio questo è il
bello: un autore commerciale a questo punto si sarebbe attaccato a Montalbano, e
tanti saluti al romanzo storico e all’Ottocento. Ma Camilleri scriveva perché si
divertiva: ed è evidente che scrivendo La concessione del telefono si è
divertito molto.
Avanzerei l’ipotesi
che all’inizio volesse scrivere un romanzo epistolare, tutto fatto di Cose
scritte. Poi, a un certo punto, si è accorto che in questo caso il limite
espressivo era troppo forte, e ha deciso di alternare le sezioni di Cose dette,
cioè di dialoghi. Che non significa certo aver ceduto di fronte a una difficoltà
tecnica scegliendo la strada più facile, perché la sfida a questo punto
diventava ancora più appassionante: il romanzo si trasformava in una suite
musicale in cui al ritmo delle lettere, dei rapporti e dei telegrammi si
alternava quello più serrato dei dialoghi, in entrambi i casi senza alcun
intervento del narratore onnisciente, senza nessuna descrizione se non quelle
fornite dagli stessi protagonisti. I dialoghi acquistano a questo punto –
diciamolo, giacché di telefoni stiamo pur sempre parlando – il ruolo che nel
dossier di un’inchiesta hanno oggi le intercettazioni telefoniche, e la loro
inserzione non riduce affatto la sensazione complessiva di avere di fronte, per
l’appunto, un miracoloso scartafaccio, in cui un investigatore venuto dopo abbia
riunito tutti i materiali di cui gli investigatori dell’epoca potevano avere,
tragicamente per loro, solo un’immagine parziale.
S’è divertito,
dicevamo: nell’immaginare, all’occasione, la toponomastica di quella Vigàta
umbertina – via dell’Unità d’Italia, manco a dirlo –, gli strafalcioni dei
parlanti semicolti (“amicus Pilato, sed magis amica veritas”), i nomi dei
comprimari (l’ex questore Bàrberi - Squarotti). Quando si avventura in territori
più esotici, è anche possibile rintracciare le sue fonti di ispirazione. Il
pesantissimo accento piemontese del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, pardon,
de Saint-Pierre, Comandante Generale dell’Arma dei Reali Carabinieri in Sicilia,
viene dritto dall’intervista impossibile di Vittorio Sermonti al re Vittorio
Emanuele II, realizzata nel 1974 nel quadro di quel memorabile programma
radiofonico, a cui un Camilleri allora quasi cinquantenne collaborava
regolarmente come regista; e l’esclamazione in dialetto che sfugge al generale
(“non sia pilông che n’dì sensa pan!”) è presa di peso dall’intervista
impossibile di Umberto Eco a Pietro Micca, di cui proprio Camilleri fece la
regia. Mentre “la carta d’indintirintà” che Mariano Giacalone chiede a Pippo
Genuardi rifiutandosi di riconoscerlo è un esito appena sicilianizzato della
“carta d’indindirindà” di Peppino De Filippo nei panni di Pappagone, che impazzò
in televisione fra il 1966 e il 1970 e che rimane tuttora indimenticato in
quella generazione, come dimostra un rapido sondaggio in Internet (oltre alla
memoria di chi scrive).
Il Maestro, dunque,
si diverte; e con lui si diverte il lettore, continuamente accompagnato
dall’ironia dell’autore e dagli snodi via via più esilaranti di una classica
commedia degli equivoci (e come si vede che Camilleri è stato a lungo
innanzitutto uomo di teatro).
Ma il divertissement non fa solo ridere, anzi, a un certo punto rischia di non
far più ridere per nulla. Perché se all’inizio il precipitare dell’intreccio
verso l’assurdo sembrava solo il frutto della dabbenaggine o, al contrario,
della troppo contorta e sospettosa astuzia dei protagonisti, via via che si
procede diventa fin troppo evidente che dietro c’è di più, e di peggio; c’è
l’eterno dramma della burocrazia italiana, ma soprattutto un pessimismo
millenario che dà per scontato che le cose cominciate male finiranno peggio, che
chi prova a portare tra i pazzi un minimo di razionalità e di buon senso finirà
stritolato, che ogni sistema premia i peggiori. Non diciamo di più, per non
spoilerare, come orrendamente diciamo oggi; d’altra parte, quando una parola la
capiscono tutti ed esprime esattamente e con la massima economia un concetto
preciso e complesso, sarebbe sbagliato non usarla, anche se scommetterei che al
Maestro avrebbe fatto venire il nirbuso. Perché questo, come quasi tutti
i libri di Camilleri, è anche un giallo, e così intricato che forse nemmeno
Montalbano sarebbe riuscito a risolverlo, anche se qui al lettore il giallo è
presentato a rovescio rispetto a quel che succede di solito: è l’intreccio delle
cause che si aggroviglia sotto i nostri occhi, il delitto non c’è ancora stato.
Alessandro Barbero (pubblicata
su
il Fatto Quotidiano, 12 marzo 2025,
col titolo Cent’anni di Camilleri: il maestro si diverte)
|